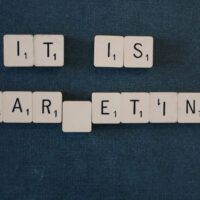In questo contenuto parliamo di
Il white paper è stato presentato in occasione del convegno AIUCD 2021 – DH per la società: e-guaglianza, partecipazione, diritti e valori nell’era digitale svolto dal 19 al 22 gennaio 2021 (a questo link puoi vedere il programma). E’ stato recentemente aggiornato in alcune sezioni, in particolar modo per quanto riguarda i dati statistici.
ABSTRACT
Negli ultimi anni le discussioni e le iniziative per rendere le nostre città più smart si sono moltiplicate, con risultati altalenanti e dipendenti più dalla caparbietà dei singoli che da una capacità diffusa a livello di sistema. Molto spesso ci si è concentrati sull’aspetto tecnico delle smart cities, tralasciando quasi ovunque il ruolo centrale delle persone in questa trasformazione; ma un luogo, una città, una comunità quanto possono davvero definirsi intelligenti se i cittadini non riescono a superare il digital divide di tipo culturale e a diventare parte integrante di essa? Per aiutare l’Italia ad uscire dal grave ritardo rispetto alla maggior parte delle nazioni europee, si stanno muovendo istituzioni, pubblica amministrazione centrale e locale, aziende pubbliche e private, mondo dell’istruzione a tutti i livelli, gruppi di interesse ed entità del Terzo Settore.
PAROLE CHIAVE
Alfabetizzazione digitale, Associazioni, Cittadini, Collaborazione, Co-progettazione, Digital divide, Istituzioni, Pubblica Amministrazione, Terzo Settore.
COS’È IL DIVARIO DIGITALE
L’espressione divario digitale (traduzione letterale del termine anglofono digital divide), è nata in seno all’amministrazione statunitense all’epoca della presidenza Clinton (1993-2001) ed indica la disparità nelle possibilità di accesso ai servizi telematici tra la popolazione. L’uso dell’espressione è oggi diffuso a livello mondiale ed, in generale, viene usato per indicare la consapevolezza globale di una problematica di accesso ai mezzi di informazione e di comunicazione digitali, da parte di determinate aree geografiche o fasce di popolazione. In maniera più semplice, oggi il digital divide può essere definito come il punto di separazione tra chi ha accesso alla rete Internet ed è in grado di utilizzare tecnologie digitali e chi invece ne rimane escluso o fortemente penalizzato. I motivi dell’esclusione possono essere molteplici: condizioni economiche, livello di istruzione (digital divide culturale), presenza e qualità dell’infrastruttura di connessione alla rete mobile o fissa (digital divide infrastrutturale), differenza di età (digital divide intergenerazionale), di sesso (digital divide di genere) e di etnìa (digital divide linguistico-culturale).
IL DIGITAL DIVIDE CULTURALE IN ITALIA
Per quanto riguarda l’Italia, la situazione nella lotta al divario digitale non è rosea: l’ultima edizione dell’indice DESI (Digital Economy and Society Index) [1], pubblicato nel 2022, certifica ancora una volta l’arretratezza del nostro paese nella classifica che ha l’obiettivo di mappare il grado di digitalizzazione dell’economia e della società delle nazioni europee. Pur avendo guadagnato alcune posizioni negli ultimi anni, nel 2022 l’Italia si trova in diciottesima posizione tra gli stati dell’Unione Europea (UE), al di sotto della media delle altre nazioni del vecchio continente. Tra le tante criticità, spicca il grave ritardo (quart’ultima posizione in UE) del c.d. “capitale umano” in termini di competenze digitali di base e avanzate; a questo si aggiunge che il numero di specialisti e laureati nel settore ICT è al di sotto della media UE.
Il fenomeno ha quindi ampie ripercussioni negative sull’uso effettivo delle tecnologie digitali da parte dei cittadini italiani. L’incremento quantitativo e qualitativo dell’offerta di servizi di e-government (termine derivato per analogia da e-business, che identifica l’ambito disciplinare relativo alle attività delle pubbliche amministrazioni realizzate grazie all’ausilio delle reti telematiche e della rete Internet) e business (si pensi ad esempio all’aumento del numero di piattaforme per gli acquisti online o della disponibilità di strumenti per il lavoro remoto o per la didattica a distanza durante le misure di confinamento dovute all’epidemia COVID-19) sembra quindi un’azione di puro adeguamento verso l’auspicata digitalizzazione dei servizi, ma privo di reale utilità pratica a causa del mancato utilizzo strutturale, diffuso e generalizzato da parte della collettività.
IL RUOLO DI GOVERNANCE DEL SETTORE PUBBLICO
Dai risultati emersi con l’indice DESI 2022 risulta evidente come il ruolo di guida e di governance della pubblica amministrazione centrale e locale abbia di fatto fallito qualsiasi tipo di politica e di azione focalizzata sul superamento del divario digitale tra i cittadini italiani. Sono ancora pochissime le istituzioni locali con un assessorato dedicato alla trasformazione digitale o alla smart city, ed un po’ ovunque – da nord a sud – si può toccare con mano lo scadente livello di trasformazione digitale della macchina comunale e la lentezza con cui i comuni e le regioni si stanno dedicando alla conversione tecnologica della PA locale.
In questo scenario, il Terzo Settore può giocare un ruolo importante nella collaborazione con tutte quelle pubbliche amministrazioni che vogliano riconoscere un ruolo attivo al mondo dell’associazionismo. Questo ruolo può portare ad una stretta collaborazione tra istituzioni pubbliche e Terzo Settore con l’obiettivo di ottenere la massima inclusione nelle politiche di alfabetizzazione digitale che vanno portate avanti in maniera capillare e trasversale, anche nei confronti delle fasce più deboli della società (giovani a bassa scolarizzazione, NEET – Not in Education, Employment or Training, immigrati, persone con disabilità, adulti over 50 esclusi dal mondo del lavoro, donne sole non occupate o con figli, anziani, persone detenute).
Le associazioni del territorio, da sempre schiacciate dalla capacità economica di pubblico e privato, hanno quindi l’occasione per dimostrare di poter dare un enorme contributo alla causa della lotta all’esclusione digitale di singoli individui o di gruppi sociali, grazie ad un approccio snello dal basso verso l’alto e sfruttando al meglio ciò che è nella loro natura: essere persone che fanno cose per le persone.
Le relazioni fra PA ed Enti di Terzo Settore dovranno essere ispirate ai principi di perseguimento dell’interesse pubblico, di efficacia, di trasparenza e, più in generale, di buon andamento della PA. La pubblica amministrazione, quindi, dovrebbe agire per riconoscere e coordinare le entità di volontariato presenti sul territorio utili ad affrontare la lotta al digital divide, potenziando e amplificando l’azione allocando a tale scopo le risorse utili a raggiungere gli obiettivi condivisi e prefissati.
AFFRONTARE IL DIVARIO DIGITALE
Affrontare il divario digitale culturale non è cosa semplice, e la costruzione del cittadino digitale (per cittadinanza digitale si intende l’insieme di diritti/doveri che, grazie al supporto di una serie di strumenti e servizi come identità, domicilio e firma digitale, ha l’obiettivo di semplificare il rapporto tra i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione tramite le tecnologie digitali) del futuro va affrontata con serietà e determinazione.
Secondo recenti stime dell’Ocse, in Italia circa il 26% della popolazione tra i 16 e i 74 anni non ha mai navigato in rete, al fronte di una media del 14% negli altri Paesi dell’Organizzazione. Si tratta di 10 milioni di cittadini che non utilizzano Internet, e questo risulta essere uno degli elementi bloccanti verso l’uso diffuso di servizi mediati dalla rete. Non può essere considerato un caso se, già dal 2012, il Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite ha approvato la risoluzione A/HCR/20/L.13, considerando espressamente l’accesso e l’utilizzo della rete Internet come uno strumento di circolazione delle idee e delle informazioni ed un insostituibile mezzo di attuazione dei diritti fondamentali dell’uomo e del cittadino.
Riuscire a progredire nell’alfabetizzazione digitale di base può consentire alle persone un accesso ed un utilizzo consapevole dei servizi online sia pubblici sia privati e, cosa ancor più importante, riuscire a dare un minimo set di competenze ed informazioni per poter poi procedere con l’auto-formazione online attraverso i molteplici canali messi a disposizione dalla rete internet (blog, siti di informazione, corsi online, webinar, ecc.).
Lo strumento principale che il Terzo Settore può mettere a disposizione della collettività è l’opera di tutoraggio diffuso verso le persone, sia all’interno delle associazioni stesse sia presso i cittadini più vicini sul territorio. Questo genere di tutoraggio si può declinare in molti modi: nella formazione digitale generica o specialistica, nell’organizzazione di corsi o conferenze, fino ad arrivare ad attività più mirate come l’affiancamento e la consulenza one-to-one. Affrontare questa sfida partendo dal territorio nel quale è radicato il mondo dell’associazionismo non profit rende immediata la conoscenza e la percezione di necessità e bisogni, riuscendo ad evidenziare azioni macro e micro, frange deboli e/o emarginate nella popolazione. L’associazione o il soggetto non profit diventano quindi un cuscinetto sociale che aiuta a semplificare il rapporto tra cittadini ed istituzioni e a mettere in campo azioni concrete per il superamento del divario digitale in ambito sociale, generazionale, economico, culturale e di genere.
In questa sfida il Terzo Settore non può essere lasciato solo: il ruolo delle istituzioni con una visione strategica a medio-lungo termine è basilare e deve andare nella direzione di mantenere una funzione di governance dell’interoperabilità del sistema pubblico-privato-Terzo Settore, fungendo anche da garante per una collaborazione e co-progettazione scevra da interessi di parte. La definizione delle strategie d’azione dev’essere implementata da soggetti istituzionali che possano definire i bisogni, controllare la corretta messa in campo di tutte le azioni necessarie e innescare processi di miglioramento nel modo con cui si fanno le cose. Fare rete diventa dunque la chiave per mettere a fattore comune dati, informazioni, buone pratiche ed esperienze.
ESEMPI CONCRETI DI APPLICABILITÀ DEL MODELLO
In Italia ci sono già state un buon numero di applicazioni pratiche relativamente a questo paradigma di collaborazione tra associazioni e pubblica amministrazione locale, con l’obiettivo comune di ridurre il divario digitale culturale tra i cittadini del territorio.
Come non citare le esperienze pionieristiche dei Punti Roma Facile [2], dei PAAS della Toscana [3], del progetto P3@Veneti [4], del progetto Pane e Internet dell’Emilia-Romagna [5] o dei Punti Genova Digitale [6] e del precedente progetto pilota Genova Digitale [7] che, con modalità del tutto simili, hanno permesso di sperimentare sul campo la cooperazione tra istituzioni e Terzo Settore, portando le attività di alfabetizzazione digitale sul territorio, in prossimità dei luoghi fisici vissuti giornalmente dai cittadini.
Le sedi di varie associazioni del territorio oppure, come nel caso di molti progetti sopra menzionati, i locali messi a disposizione da municipi o enti pubblici sono diventati naturali punti di contatto tra il cittadino e i facilitatori digitali che mettono a disposizione le proprie conoscenze e competenze.
È degna di nota anche l’attività svolta in collaborazione tra l’associazione Informatici senza Frontiere (ISF) e il Liceo Montessori di Roma [8]. Per questo progetto, gli studenti hanno lavorato come tutor nei corsi di informatica realizzati per gli anziani da ISF. Il gruppo di lavoro in fase di progettazione era composto da soci ISF e insegnanti, ed ha definito le linee generali di progetto, gli obiettivi e le modalità di erogazione della formazione.
Un’altra recente iniziativa nell’ambito delle competenze digitali è la stesura del libretto #DIGIfenditi, manuale di autodifesa personale [9], progettato dal Municipio Roma VII insieme a una serie di gruppi e società del settore (tra cui TSCAI – The Smart City Association Italy e Stati Generali dell’Innovazione). Nel vademecum sono affrontati i temi dell’utilizzo consapevole di smartphone e tablet, dei social network, delle password, della posta elettronica e di tutti ciò oramai che fa parte della vita quotidiana delle persone, ma necessita di attenzione per far fronte alle insidie digitali nascoste dietro lo schermo.
RISULTATI OTTENUTI
Non è stato possibile reperire informazioni dettagliate sui risultati ottenuti da tutti i progetti sopra menzionati; si ritiene tuttavia che, anche grazie alle caratteristiche di replicabilità di questi progetti, i risultati possano essere facilmente perseguiti da qualsiasi associazione che voglia impegnarsi attivamente sul proprio territorio (anche con un numero limitato di facilitatori digitali).
I Punti Roma Facile sono strutturati in 26 punti operativi (dati aggiornati a giugno 2018) in tutto il territorio di Roma, di cui 17 attivati presso luoghi istituzionali messi a disposizione dai municipi. Altri 7 sono invece stati predisposti presso il Sistema Bibliotecario di Roma, e ulteriori 2 presso associazioni che hanno aderito all’iniziativa. Nel periodo novembre 2016-luglio 2017 ogni singolo Punto Roma Facile ha mediamente erogato 12 ore settimanali di formazione, per un totale di 2.500 cittadini che hanno usufruito di questa possibilità.
Il progetto PAAS della Toscana, nato tra il 2004 e il 2005, si è sviluppato negli anni successivi fino a rimanere in stand by a cavallo tra il 2018 e l’inizio del 2019. Nel 2018 la rete territoriale era composta di 156 punti PAAS collocati in sedi associative e di enti, diffusi in 95 comuni su 273 totali dell’intera regione. Negli anni precedenti (nel periodo 2007-2015), quando erano stati resi disponibili alcuni finanziamenti di sostegno specifici, si era arrivati ad avere 298 punti in 192 comuni (che rappresentano circa il 67% dei 287 comuni presenti all’epoca sul territorio toscano).
I risultati del progetto pilota Genova Digitale sono stati presentati nel novembre 2015 alla Reggia di Venaria (TO), durante l’Italian Digital Day, davanti alla presidenza del Consiglio dei Ministri. L’iniziativa genovese ha visto il coinvolgimento di 3 diversi assessorati (Sviluppo Economico, Informatica e Rapporti con i Municipi) e di tutti i municipi che compongono il capoluogo ligure (9). La durata dell’iniziativa di formazione è stata di circa 1 mese, ed ha visto l’organizzazione di 74 incontri pubblici dove sono stati affrontati alcuni argomenti di base sull’utilizzo di alcune applicazioni per smartphone di pubblica utilità. Tutto il progetto è stato gestito grazie al contributo di 27 associazioni del territorio e di 23 facilitatori digitali. Inoltre, tra novembre 2017 e novembre 2019 sono stati organizzati alcuni ulteriori eventi formativi sul territorio con il nome Punti Genova Digitale, che hanno visto un totale di 84 ore di formazione one-to-one erogate ai cittadini che ne hanno fatto richiesta.
L’attività di tutoraggio nei corsi di informatica organizzati da ISF si sono svolte presso due Centri Anziani in due diverse zone di Roma (Trastevere e Conca d’Oro). Gli studenti/tutor sono stati guidati e seguiti dai volontari ISF che già operano con queste finalità presso le due strutture coinvolte. Nel 2018-2019 il progetto ha coinvolto 22 studenti e circa 25 anziani mentre nel 2019-2020 il progetto ha coinvolto 30 studenti e circa 35 anziani. Un ulteriore gruppo di 15 studenti ha iniziato il percorso a fine gennaio 2020 ma dopo le prime due giornate di formazione è stato necessario interromperlo a causa delle restrizioni Covid-19. Gli studenti sono stati impegnati in una prima fase dedicata alla loro formazione allo scopo di prepararli al tipo di insegnamento a cui avrebbero dovuto fare fronte, di durata pari a circa 10 ore. Successivamente si sono svolte le attività di formazione/tutoring, per una durata complessiva di circa 16-18 ore. Infine è stato loro richiesto di elaborare l’esperienza svolta redigendo una relazione, con un impegno stimato pari a circa 4-6 ore.
BIBLIOGRAFIA
[1] European Commission, “The Digital Economy and Society Index (DESI)”, 2022. https://digital-strategy.ec.europa.eu/it/policies/desi[2] Roma Capitale, “Punti Roma Facile”. https://www.comune.roma.it/web/it/attivita-progetto.page?contentId=PRG95508
[3] Regione Toscana, “PAAS Cittadini”. http://mappe.regione.toscana.it/webstat/paas/descrizione_rete_paas.html
[4] Regione del Veneto, “Il progetto P3@”. https://www.regione.veneto.it/web/informatica-e-e-government/p3a-veneti
[5] Regione Emilia-Romagna, “Pane e Internet”. https://www.paneeinternet.it/
[6] Associazione Open Genova, “Punti Genova Digitale”, 2019. https://associazione.opengenova.org/progetti/punti-genova-digitale/
[7] Comune di Genova, progetto pilota “Genova Digitale”, 2015. https://www2.comune.genova.it/content/progetto-genova-digitale-concluso-il-percorso-di-partecipazione
[8] Informatici Senza Frontiere, “Quando i giovani fanno da tutor agli anziani: racconto di un’esperienza”, 2020. https://www.informaticisenzafrontiere.org/quando-i-giovani-fanno-da-tutor-agli-anziani-nei-corsi-di-informatica-racconto-di-unesperienza/
[9] Municipio Roma VII, “#DIGIfenditi, manuale di autodifesa personale”, 2020. https://www.comune.roma.it/web/it/notizia/digifenditi-manuale-di-autodifesa-digitale.page
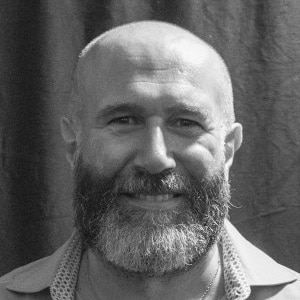
L’innovazione, il web e la tecnologia fanno parte del mio mondo lavorativo e delle mie passioni. Mi piace pensare alle città intelligenti del futuro, e poter contribuire alla loro progettazione.